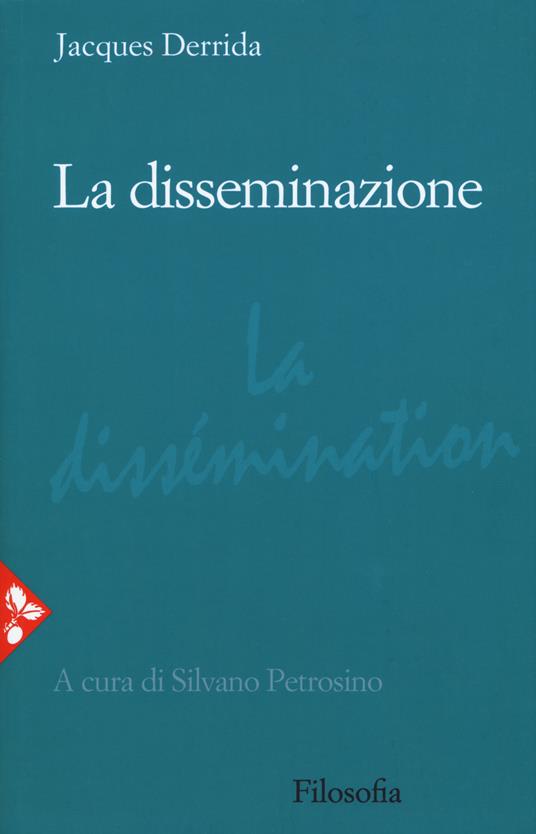Salvare Derrida dall’attivismo woke: contro l’abuso moralistico del concetto di decostruzione
Decostruzione. Derrida non voleva essere un maestro di condotta. E meno che mai un confessore. Il libro "La disseminazione".
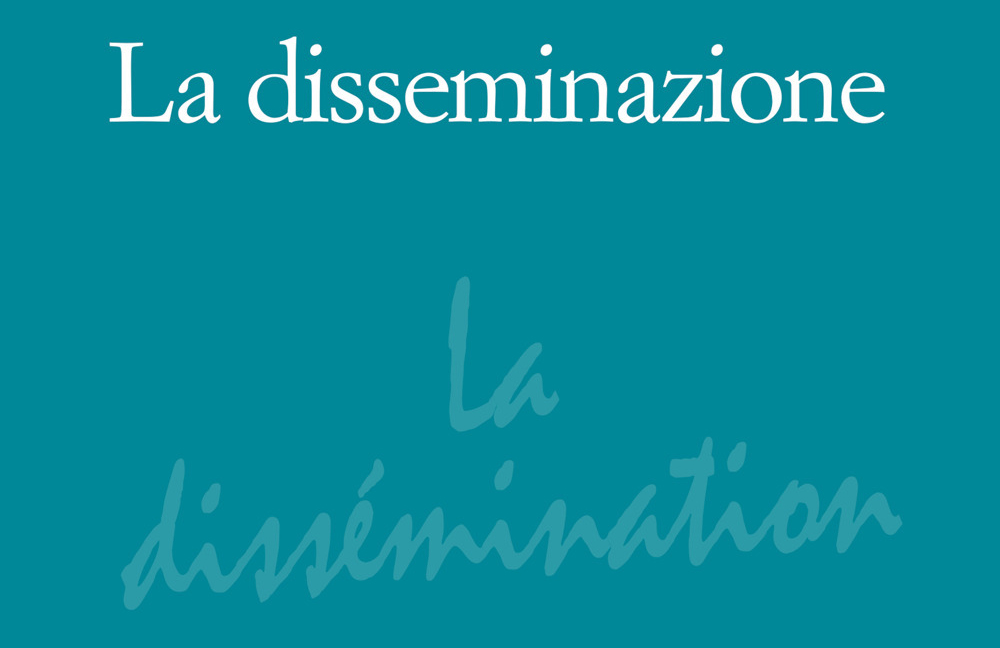
Decostruzione. Derrida non voleva essere un maestro di condotta. E meno che mai un confessore. Il libro "La disseminazione".
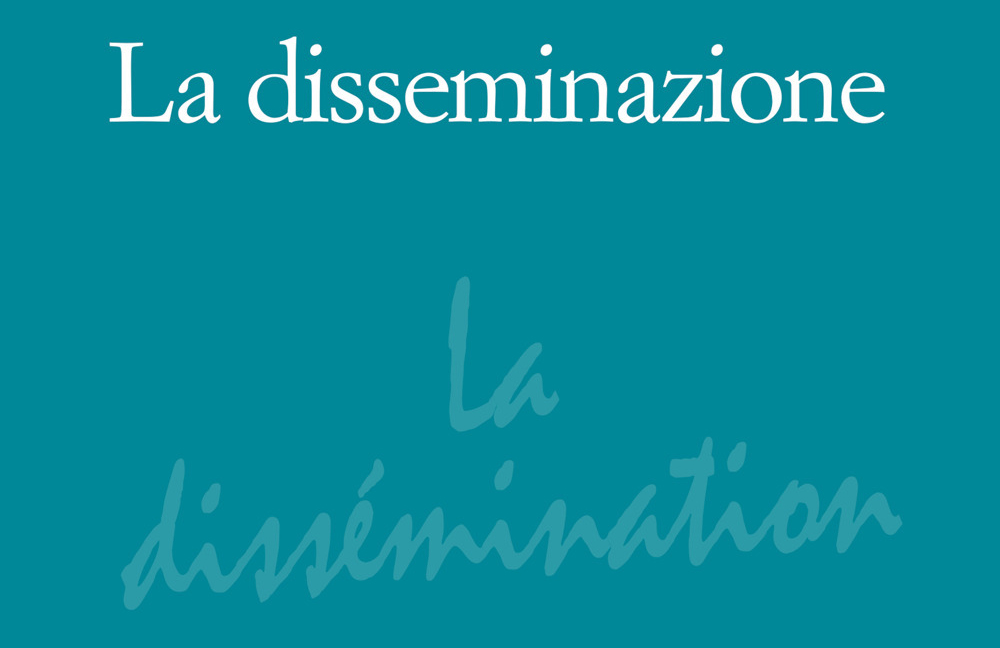
Negli ultimi anni, nelle pratiche e nei linguaggi di una certa militanza di sinistra, si è imposto un uso sempre più ricorrente – e superficiale – dell’espressione “decostruire sé stessi“. In particolare nei contesti legati all’attivismo identitario, alle politiche del riconoscimento, all’antirazzismo o al femminismo intersezionale, si è diffusa l’idea che il soggetto privilegiato (bianco, maschio, borghese, eterosessuale) debba “decostruirsi“, mettere in discussione la propria posizione, i propri privilegi, il proprio linguaggio. Si tratta, a ben vedere, di una variante della confessione pubblica, della colpa interiorizzata, della volontà di redenzione che si offre come testimonianza politica. Ma ciò che sorprende è che questo linguaggio moraleggiante, per non dire penitenziale, si accompagni spesso a un riferimento esplicito alla teoria della decostruzione di Jacques Derrida.
Ecco allora il paradosso: il concetto di decostruzione, che in Derrida nasce come critica radicale dell’ontologia del soggetto, viene oggi mobilitato per costruire un’etica della trasparenza soggettiva. La decostruzione, che smonta ogni pretesa di fondazione, viene trasformata in un programma di riedificazione etica. In breve: Derrida viene tirato per la giacchetta per legittimare un’opzione teorica che è l’esatto contrario della sua filosofia.
Cominciamo dal nodo linguistico. “Decostruirsi” è un verbo che non esiste nel lessico derridiano. Derrida parla della decostruzione come di un processo che accade, non come di un atto volontario o prescrittivo. In una delle sue formule più note, egli afferma che la decostruzione non si fa, ma “arrive”, accade, si produce nei testi, nelle istituzioni, nei concetti, mostrando ciò che essi rimuovono o escludono per potersi costituire. Non c’è un soggetto che decide di decostruire qualcosa, tantomeno sé stesso. Non si tratta di un gesto di volontà, di una prassi morale, di una prassi militante. La decostruzione è un evento interno al linguaggio e alla scrittura, che disarticola i dispositivi metafisici su cui si fondano i concetti della tradizione occidentale.
L’uso militante della decostruzione parte da un presupposto: che il soggetto possa, attraverso un lavoro di autoanalisi e autocritica, prendere coscienza della propria posizione e dei propri privilegi, e quindi “decostruirli”. Ma questo presupposto è esattamente ciò che Derrida mette in crisi. In tutta la sua opera, egli mostra come il soggetto non sia mai presente a se stesso, non sia mai padrone del proprio discorso, non possa mai fondarsi come origine. Il soggetto è sempre già preso nella rete della differenza, del differimento, della scrittura, dell’altro. Pretendere di decostruirsi equivale a reiterare la vecchia idea di un Io sovrano che si osserva e si plasma: un’idea cartesiana o husserliana, non derridiana.
Inoltre, la decostruzione non mira alla confessione dei privilegi, ma alla messa in crisi delle opposizioni binarie (dentro/fuori, uomo/donna, ragione/folle, natura/cultura, ecc.) che reggono la metafisica dell’Occidente. Essa non serve a “liberare” il soggetto, ma a mostrare che il soggetto non è mai libero, perché è strutturalmente scisso, fondato su esclusioni e rimozioni.
Il rischio di questa torsione militante del pensiero derridiano è duplice. Da un lato, si riduce la decostruzione a un codice comportamentale: controllare il linguaggio, riconoscere i propri privilegi, chiedere scusa, decentrarsi. Dall’altro, si crea una nuova ortodossia etico-discorsiva, che misura le soggettività sulla base della loro adesione a un ideale di purezza linguistica e consapevolezza politica. La decostruzione diventa così uno strumento di colpevolizzazione, non di liberazione.
Ma Derrida ha sempre rifiutato ogni etica normativa. La sua riflessione sull’etica è tesa all’indecidibile, all’inatteso, all’impossibile: non alla codificazione di una serie di regole di comportamento, ma all’apertura dell’altro come irriducibile. La sua decostruzione della giustizia, in “Forza di legge”, è un esempio magistrale di questa etica dell’altro, che nulla ha a che vedere con il moralismo delle identità.
Salvare Derrida significa restituire alla decostruzione il suo statuto teorico radicale, non ridurla a una pratica di autocontrollo o a un atto performativo di confessione. La militanza ha tutto il diritto di elaborare i propri linguaggi e strumenti critici, ma non può abusare dei concetti teorici fino a snaturarli.
Se vogliamo criticare il privilegio, la dominazione, l’oppressione, dobbiamo farlo a partire da un’analisi delle strutture materiali, istituzionali che li riproducono, non da una richiesta permanente di autocritica individuale. La decostruzione può contribuire a questa analisi, ma solo se rimane ciò che è: una strategia di lettura, una filosofia dell’indecidibile, una politica dell’impossibile. Non un atto di fede, né un’esortazione morale.
Derrida non voleva essere un maestro di condotta. E meno che mai un confessore.
Consigliamo ai lettori di tornare alla fonte e leggersi Lettura consigliata: Jacques Derrida, La disseminazione (1972), trad. it. a cura di A. Prete, Milano, Jaca Book, 1984.