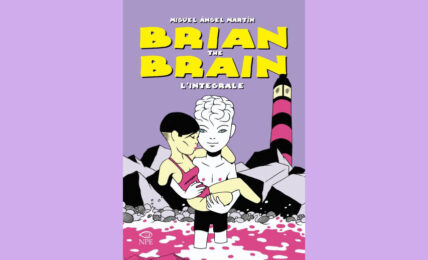Falene arrosto e meta-narrazioni efficaci: giocare per credere
Giocare a far Dio: è la possibilità offerta da un videogioco narrativo attraverso la procedural generation. Ma non tutti i videogames narrativi la usano. Per esempio Thimbleweed Park è un prodotto ibrido di grande fascino.