“Grande Meraviglia”: un libro per capire davvero cos’è la salute mentale
Elba, una ragazza nata e cresciuta in manicomio e Fausto Meraviglia, psichiatra. Un libro che spiega davvero cos'è la salute mentale

Elba, una ragazza nata e cresciuta in manicomio e Fausto Meraviglia, psichiatra. Un libro che spiega davvero cos'è la salute mentale

La prima volta che mi sono sentita chiamare utente esperta non sapevo nemmeno cosa volesse dire. Il mondo della salute mentale era per me un percorso che avevo affrontato quasi alla cieca, per prova ed errore, da autodidatta, alla ricerca di una spiegazione per quello che mi era successo e mi succedeva.
Accade a molte persone di arrivare all’età adulta avendo vissuto sulla propria pelle i sintomi di una o più patologie mentali, senza aver mai ricevuto una vera e propria diagnosi, perché in qualche modo sono riuscite ad arrabattarsi con quello che avevano. Si finisce però così per accumulare storture su storture, traumi e compensazioni e soprattutto sintomi travestiti da soluzioni.
La miccia che mi fece esplodere fu la prima gravidanza, come capita a molte. La miccia, sì, perché la depressione post partum difficilmente arriva come un fulmine a ciel sereno, di solito è il sunto puntuale di un curriculum più articolato e complesso, proprio come il mio.
Come tutte le esplosioni che si rispettino, anche la mia ebbe il suo nutrito gruppo di spettatori increduli, di sguardi spaventati, di epifanie poco gradite.
La malattia mentale arriva nelle famiglie come l’interruzione di corrente per morosità: i segnali ci sono tutti, le responsabilità pure ma nessuno se ne era mai accorto.
A dirla tutta, accorgersene non è poi così facile, perché l’idea che abbiamo delle patologie della mente è un cocktail di folklore, racconti horror, cronaca e vecchi film. Cerchiamo alcuni segnali e ne sottovalutiamo altri, ci convinciamo che la pazzia sia qualcosa di definito, stereotipato, lontano da noi, quando la verità è che la linea che separa la buona salute mentale dalla malattia è sottilissima e si può varcare in un senso e nell’altro più volte nel corso di una vita.
E così ho percorso il viaggio terapeutico dentro alla mia mente difettosa, col desiderio di stare meglio, certo, ma soprattutto con l’atteggiamento di una scienziata che si chiede mille perché: perché io? Perché in un momento della mia vita in cui finalmente avevo trovato una specie di equilibrio? Perché la psicoterapia non mi bastava? Perché la gente intorno a me non vedeva la mia malattia, la sottovalutava, me ne faceva una colpa?
Per rispondere ho fatto molte cose: sono andata in terapia, con tre diversi terapeuti di tre diverse scuole, ho assunto farmaci e ho cominciato a studiare. Mi sono iscritta nuovamente all’Università alla veneranda età di 44 anni e ho cominciato a leggere libri di neuroscienze cognitive.
Forse per questo mio percorso ho trovato così toccante, essenziale, imperdibile Grande Meraviglia di Viola Ardone (ed. Einauidi), una storia che si snoda a cavallo della chiusura dei manicomi fino ai giorni nostri. I protagonisti sono Elba, una ragazza nata e cresciuta in manicomio solo in quanto figlia illegittima di una madre internata per adulterio (accadeva molto spesso) e Fausto Meraviglia, psichiatra collega di Basaglia che quel manicomio contribuirà a farlo chiudere. Elba e Fausto che sono quasi uno la continuazione dell’altra, una persona divisa in due, la ragazza che si riscatta dal passato ma sceglie di farlo a modo suo e il Pigmalione un po’ Narciso che fatica a trovare un confine tra l’impegno sociale e il delirio di onnipotenza.
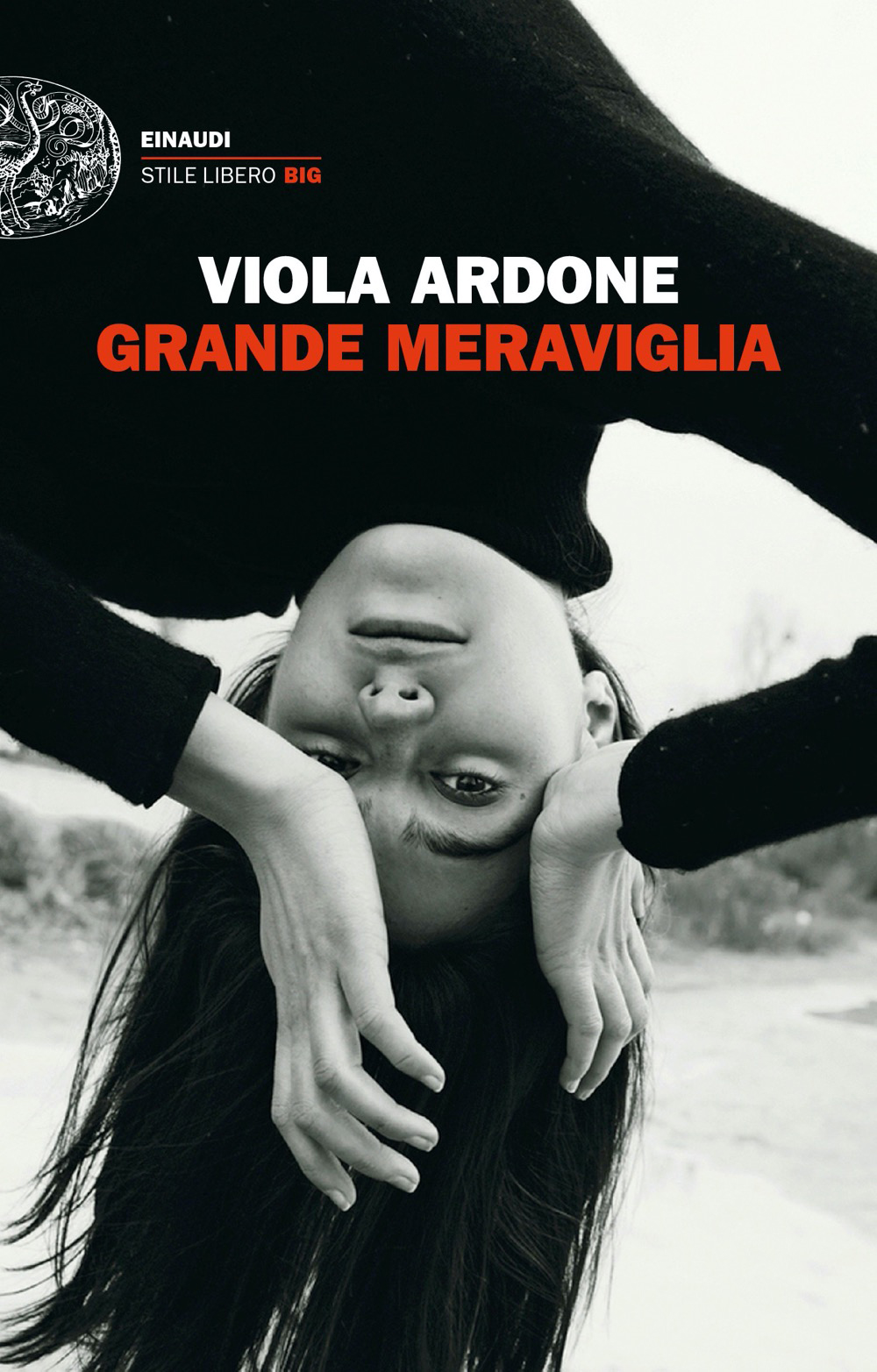
Un romanzo che racconta quella semplicità con cui sanità e pazzia si mescolano e che fa capire quanto sia facile per uno psichiatra finire per trovarsi di più coi suoi pazienti che con la sua famiglia o con i suoi amici, forse perché una volta che hai conosciuto la verità – e i matti veri sono veri sempre – fai fatica a stare nella forma e nelle bugie necessarie alla vita sociale.
Utente esperta, dicevo. Lo sono io e lo è Elba, scelta dal suo mentore per aiutare chi come lei ha attraversato il confine del mezzomondo. Persone che sono ritornate dagli inferi, hanno guadato il fiume, sono sopravvissute e possono traghettare altri con loro, riparando quella ferita primaria che difficilmente si può curare altrimenti.
