“Una cosa che non parla” racconta la scuola di oggi
Come dovrebbe essere la scuola? Giuseppe Nibali, curatore di "Una cosa che non parla" risponde a queste domande.
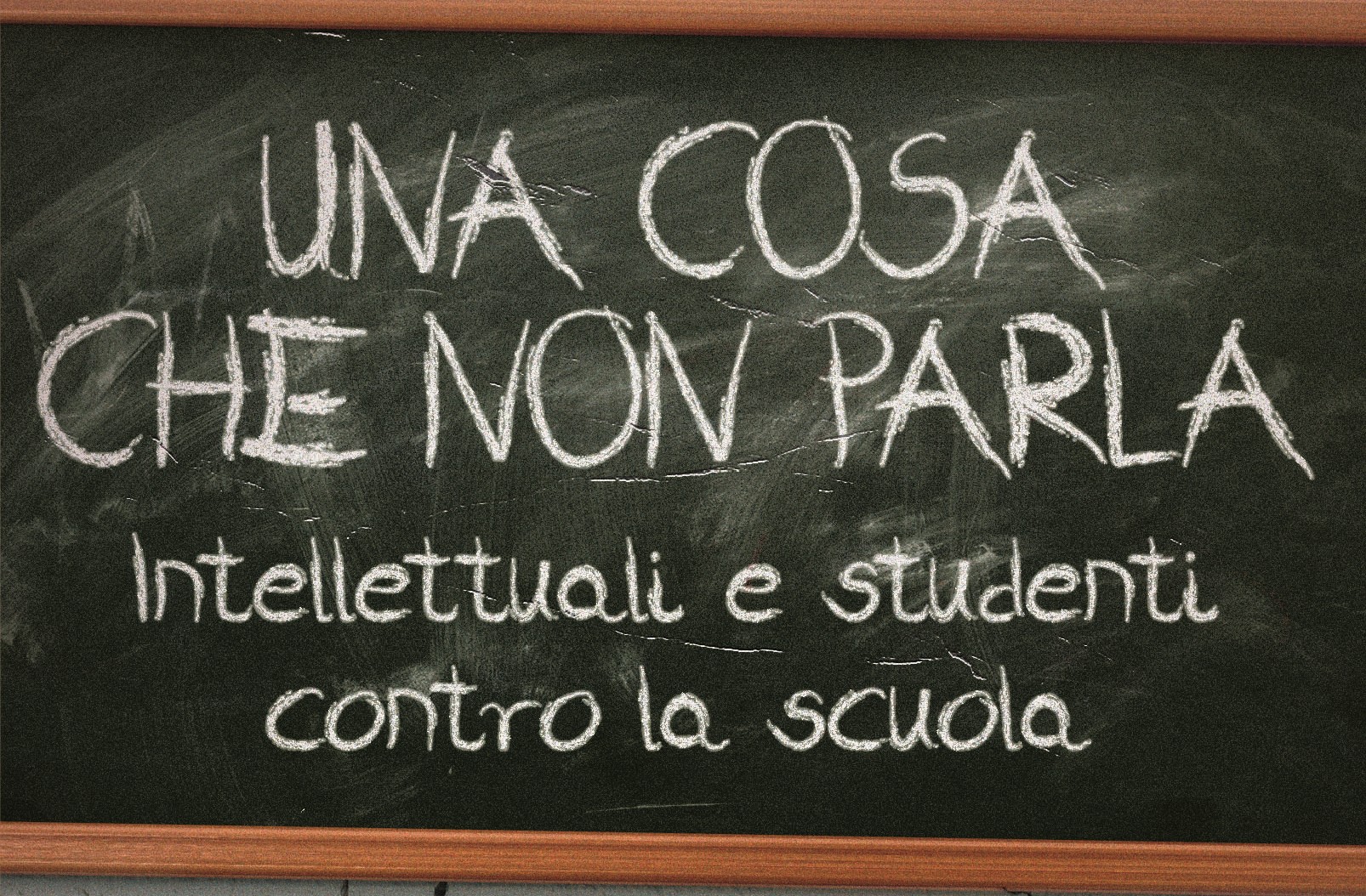
Come dovrebbe essere la scuola? Giuseppe Nibali, curatore di "Una cosa che non parla" risponde a queste domande.
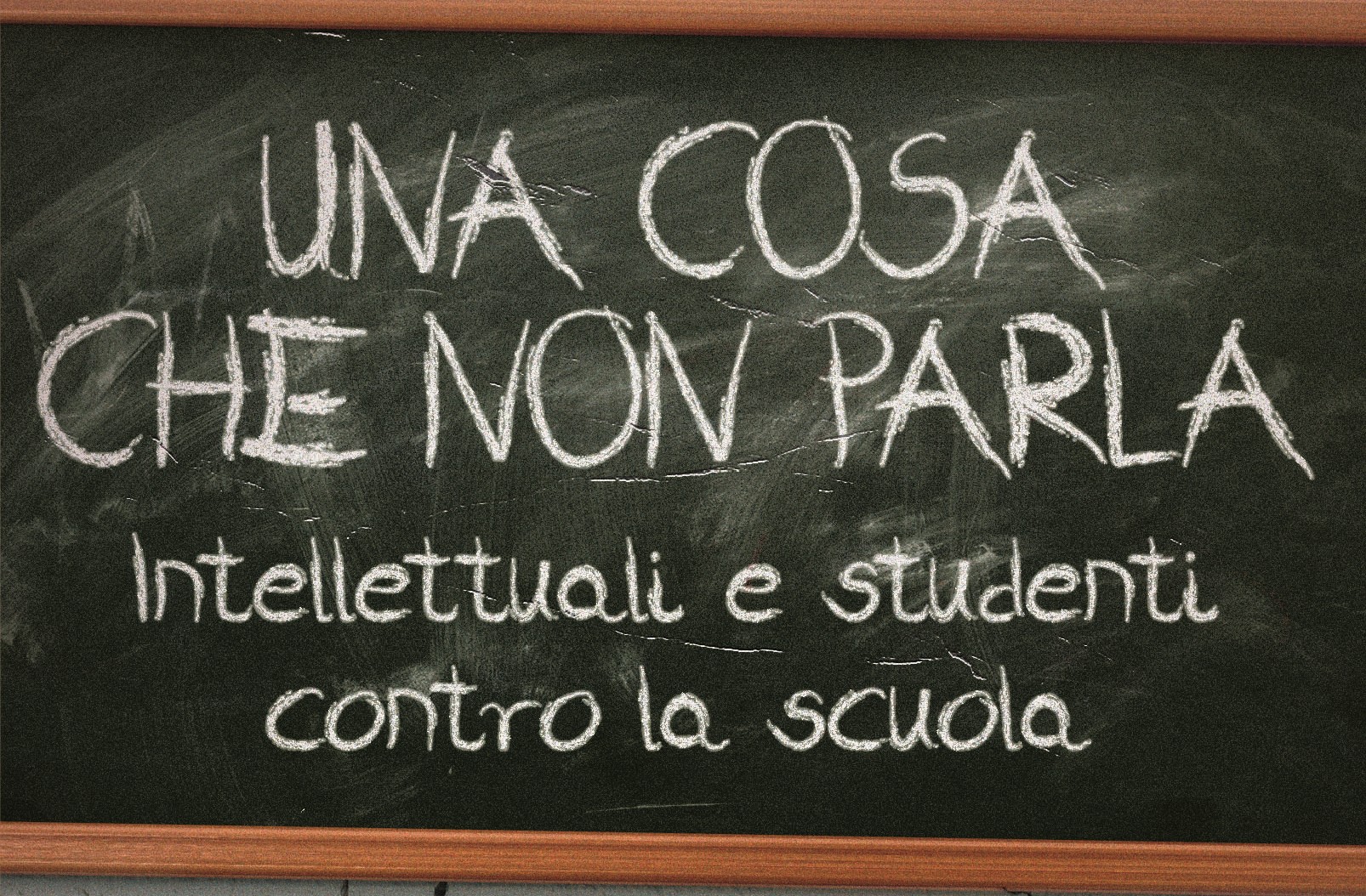
Come dovrebbe essere la scuola? Quando ha cominciato a diventare un mero luogo dove si apprende unicamente la tecnica e non la cultura? Quando ha smesso di ascoltare gli studenti e le studentesse che hanno le menti piene di idee e innovazioni spesso taciute? Quali sono le soluzioni possibili? Giuseppe Nibali, curatore di Una cosa che non parla risponde a queste domande raccogliendo interviste e testimonianze dal corpo docente, ma anche dagli allievi e dalle allieve.

Si parla tantissimo di scuola, soprattutto ultimamente. Dall’idea di inserire l’educazione affettiva come materia nel curricolo, fino al sistema di reclutamento della secondaria che sta mettendo in crisi tantissime persone che aspirano a insegnare, costringendo loro a ritmi difficilissimi e complicati e a sborsare cifre esose per abilitarsi. Giuseppe Nibali non pretende di trovare una soluzione, ma in Una cosa che non parla ha coinvolto figure di spicco del panorama culturale italiano per le discipline scolastiche che dialogano con dieci studenti e studentesse. Il punto di vista è quindi doppio. Il libro è corredato da un’introduzione dello stesso Nibali che ne spiega le intenzioni, per dare poi spazio alle interviste.
Quello che chiediamo ai nostri ragazzi è una formazione tecnica. I classicisti devono saper tradurre e gli scientifici devono saper far di conto, per non parlare degli istituti tecnici e professionali, in cui i campi del sapere sono erasi già dal titolo, a vantaggio della possibile professione futura. La scuola è utile solo nella sua funzione di educazione alle tecniche. È una macchina che si muove per competenze. Non serve altro. Ma «la fatica si fa per passione, non ci si appassiona alla fatica, e chi lo fa forse deve espiare qualcosa. Ma sulle colpe non si costruisce il gusto del sapere». Perché, bisognerebbe chiederci, ci troviamo
Giuseppe Nibali, Una cosa che non parla
oggi in questa situazione strana?
Quello che si pone in essere è un viaggio educativo dove ci sia spazio per chiunque sappia qualcosa di scuola perché la vive, il pregio principale del libro: troppe volte a parlare di cosa deve fare la scuola sono persone che, certo, l’hanno frequentata, ma non ci stanno più dentro da anni, che non lavorano dentro questa realtà, non studiano a scuola nel momento in cui ne parlano. Un’ossessione per la teoria che riempie in maniera preoccupante anche i corsi abilitanti appena attivati, come se insegnare si riducesse a una serie di tecniche e strategie particolari; mentre la formazione, per quanto fondamentale in via teorica, deve partire dai bisogni di chi si ha davanti, per comprenderne l’unicità, fare inclusione e agire in maniera interculturale.
L’aspetto interessante di un libro come Una cosa che non parla è il doppio canale di comunicazione. L’attenzione è data principalmente ai fruitori della scuola che hanno una loro voce. Riguardo agli studenti e alle studentesse, Nibali nell’introduzione spiega che sono come eroi con un’ala sola, citando il quadro Der Held mit dem Flügel (l’Eroe con l’ala) del 1905 di Paul Klee.
Quanto simili sembrano, i nostri studenti, a quell’eroe con l’ala, goffi e regali al medesimo tempo, dentro una sconfitta che sembra annunciata. Stanno nella valle crepuscolare degli uomini, dove ai loro tormentati tentativi di volo risponde il silenzio degli adulti e dello Stato che, dovendo seguire il consenso, non riesce a formulare, a livello scolastico, risposte convincenti.
Giuseppe Nibali, Una cosa che non parla
La scuola sta diventando per loro un luogo che non ascolta, è concepita come una cosa che non parla, come suggerisce il titolo, una fredda entità che non ascolta, non dialoga, non accoglie la loro voce, ma rimane muta e bloccata nella sua autoreferenzialità. L’ossessione per i voti che rendono le persone unicamente numeri, l’eccessiva burocrazia e la pressante richiesta di performance sempre migliori, schiaccia gli studenti e le studentesse in una morsa di forte insicurezza e timore. La metafora degli eroi con un’ala sola risulta estremamente funzionale in tal senso: si è chiamati, infatti, ad affrontare una scuola spesso sorda ai propri bisogni che non prepara a vivere in una società complessa e instabile. Queste imprese vanno compiute con mezzi insufficienti, da qui l’ala sola. Nelle interviste si tratta soprattutto di questo, a partire dall’utilità di determinate discipline alla formazione della persona seppur non direttamente “utili al lavoro”, fino all’ansia delle continue valutazioni che spersonalizzano l’apprendimento.
Per me, uno dei principali problemi è senz’altro legato ai metodi di valutazione, all’idea onnipresente del voto come obiettivo unico di tutto quello che si fa a scuola. In generale gli argomenti e le materie di studio mi interessano, ma mi sento molto meno stimolata e svogliata a studiare se so che c’è una verifica e verrò valutata, perché non posso studiare nel modo in cui vorrei, in un modo in cui riesco veramente a imparare e a ricordarmi le cose.
Giulia Mancuso, studentessa milanese intervistata in “Una cosa che non parla”
Non si pretende con Una cosa che non parla di trovare soluzioni univoche. Tuttavia, tutti gli interventi e il dialogo soprattutto tra i due punti di vista mettono in risalto una necessità fondamentale di questi tempi: che la scuola sia una comunità di apprendimento. Comunità significa sentirsi parte di qualcosa, non una macchina che deve funzionare e produrre, ma un universo dove al centro vi siano dialoghi, relazioni, persone. Illuminante a tal proposito è l’intervento di Alessandro Barbero che conclude il libro, testo già apparso su MicroMega dal titolo Se la scuola muore. Le criticità della scuola sono molteplici: la scarsità di risorse, la burocratizzazione, l’ossessione per la valutazione che sembra essere l’unica cosa che conti, la precarietà del corpo docente che produce enorme insoddisfazione.
Il libro che ha dato molta voce alla parte di chi riceve l’istruzione, conclude con quest’intervento riflessioni fondamentali sul ruolo dei docenti. Infatti, se anche gli stipendi spesso sono bassi, Barbero mette in risalto quanto per svolgere bene tale lavoro basterebbe poterlo attuare in serenità, senza troppa burocrazia, “com’è indispensabile per chiunque debba svolgere un’attività intellettuale impegnativa e che richiede un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze”, allora si valorizzerà anche il dialogo con l’altro e l’altra, la stessa volontà di costruire quella comunità sarà più facile da attuare. Perciò è importante leggere questo libro, per riflettere insieme su quanto ancora possiamo fare per migliorare una delle cose più preziose che abbiamo: proprio quella scuola che spesso siamo portati a disprezzare.
