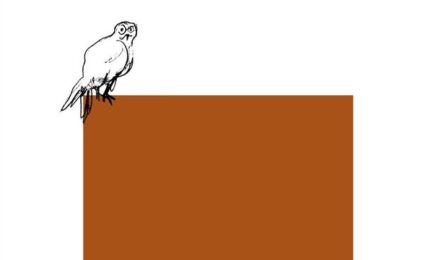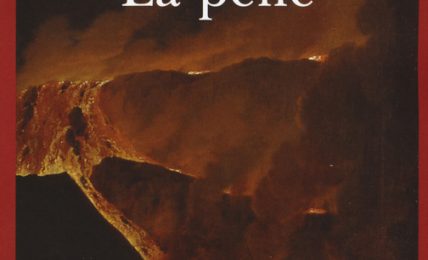Il posto composto di un padre scomodo nel romanzo della Premio Nobel Annie Ernaux
Il romanzo 'Il posto' di Annie Ernaux apre, senza ipocrisia, il vaso di Pandora dei difficili rapporti tra genitori e figli quando a dividerli sono i diversi ambiti culturali in cui si sono formati.