La “questione animale”, politiche dell’antispecismo
Affrontare la questione animale all'insegna dell'intersezionalità. Il Libro "Politiche dell'antispecismo".

Affrontare la questione animale all'insegna dell'intersezionalità. Il Libro "Politiche dell'antispecismo".

La cosiddetta questione animale è al centro di un dibattito che ha ormai una sua tradizione, a partire dai classici degli anni Settanta di Peter Singer e Tom Regan. In che modo si è sviluppato questo dibattito? In che modo, negli ultimi anni, ha incontrato altri ambiti di lotta sociale e di elaborazione teorica? Come è possibile affrontare la questione animale all’insegna dell’intersezionalità?
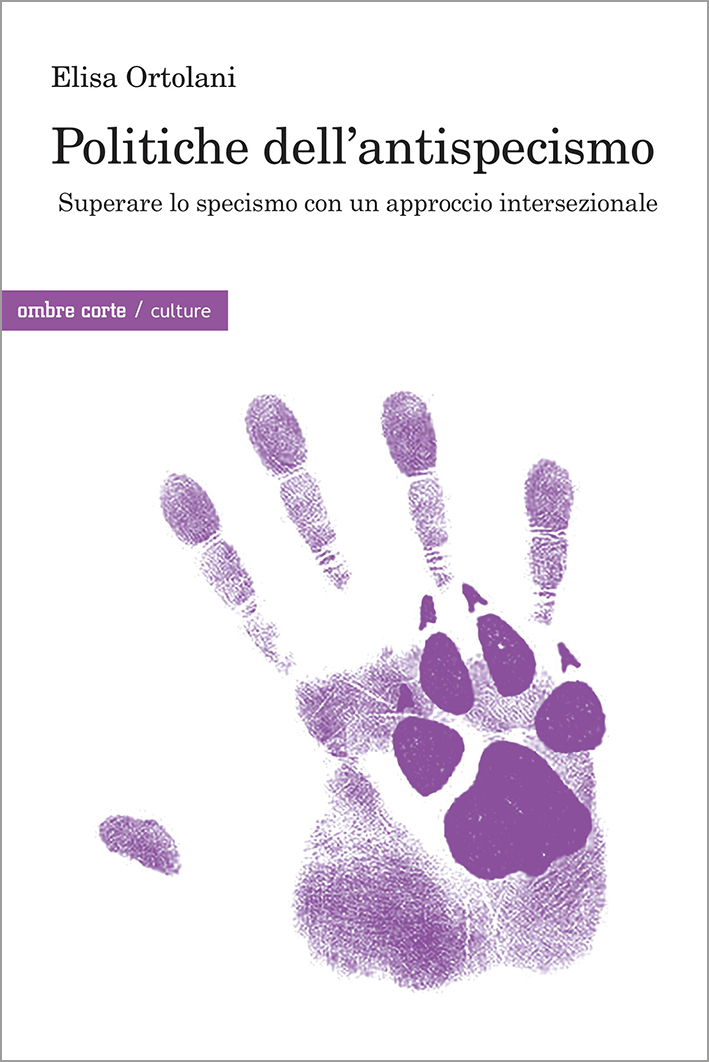
Il recente libro di Elisa Ortolani, Politiche dell’antispecismo, Ombre Corte edizioni, fa il punto sugli sviluppi del dibattito. L’autrice offre, innanzitutto, un quadro del percorso che ha visto affermarsi, in Occidente, la visione specista caratterizzata dall’antropocentrismo, dalla costruzione di un confine netto fra l’umano da una parte e tutti gli altri animali dall’altra, e, in definitiva, da un’architettura di pensiero costruita per giustificare/naturalizzare lo sfruttamento delle altre specie.
A partire quantomeno da Aristotele, infatti, si è sviluppata l’egemonia di un pensiero teso a gerarchizzare la differenza di specie. Ortolani tratteggia una sorta di genealogia dello specismo, cui fanno da contrappunto una serie di voci perlopiù isolate, come quelle di Pitagora, Giacomo Leopardi, Jeremy Bentham. L’autrice passa poi ad esaminare gli argomenti che, nella storia più recente, allo specismo si sono opposti. Prende dunque le mosse dalle teorie più tradizionali (Singer e Regan, appunto), e riassume alcune fra quelle di una successiva ondata (Roberto Marchesini, Marco Maurizi, Matthew Calarco, tra gli altri), evidenziandone gli elementi di rottura, di novità, ma anche i punti critici.
Fra gli elementi di interesse di questa breve ricostruzione che compone i primi due capitoli del libro, troviamo una sezione dedicata all’Olocausto animale, in cui è viene tratteggiato il dibattito sull’analogia fra campi di concentramento e allevamenti moderni; e una serie di considerazioni sui pet, gli animali cosiddetti d’affezione (in particolare i cani), un argomento spesso eluso o trattato superficialmente anche nell’ambito delle teorie antispeciste.
Il terzo capitolo, che costituisce il contributo più originale del lavoro di Ortolani, propone un autentico approccio intersezionale alla questione animale. Emerge qui il posizionamento transfemminista dell’autrice che, forte delle elaborazioni dell’antispecismo più politicizzato e attento agli altri movimenti, riesce a porre una serie di questioni di più ampio respiro, che negli autori citati sopra (non a caso, tutti di genere maschile!) faticano a emergere. Prende forma dunque l’obiettivo principale del libro: affrontare la questione animale all’insegna dell’intersezionalità.
Tre sono le linee di riflessione principali: la disabilità, la colonialità, il binarismo di genere. Per ognuno di questi temi, Ortolani si lascia guidare dagli spunti di alcuni testi-chiave: Bestie da soma di Sunaura Taylor per i nessi fra diritti disabili e diritti animali, unitamente alle riflessioni contenute in Cospirazione animale; Afro-ismo, la raccolta di saggi delle militanti antispeciste/antirazziste afrodiscendenti Aph e Syl Ko per la decolonizzazione dell’antispecismo bianco; Carne da macello di Carol Adams per una lettura ecofemminista della questione animale e il Manifesto queer vegan di Rasmus Simonsen per il legame fra veganismo e critica dell’eterosessualità obbligatoria.
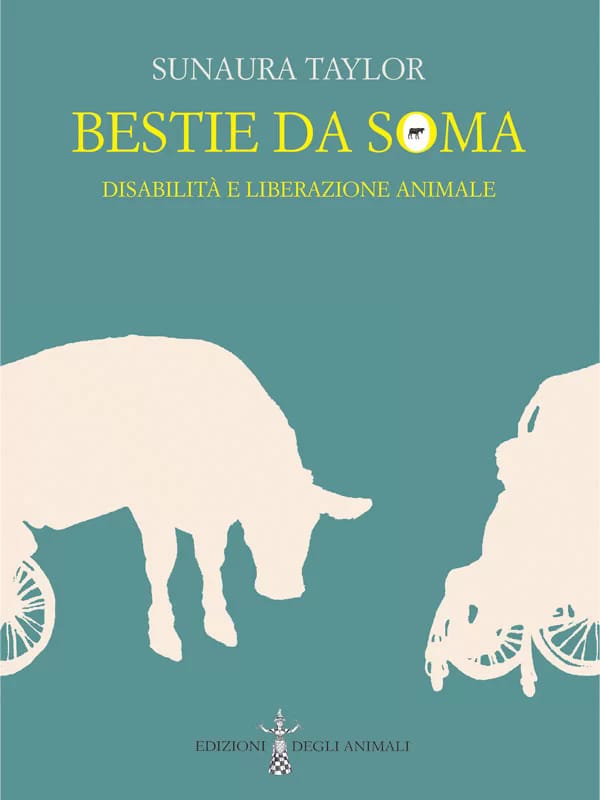
Se disabilità e liberazione animale possono sembrare temi distanti, grazie al lavoro di Sunaura Taylor sappiamo che tali non sono. Per menzionare uno fra i tanti aspetti, sappiamo che un perno fondamentale della supremazia umana è l’attribuzione di dignità proporzionale alle capacità cognitive o linguistiche: noi saremmo superiori perché più intelligenti, perché dotati di un linguaggio più complesso, perché in grado di elaborare pensieri più fini.
Da buon antispecista, ho sempre pensato che questo fosse il cuore dello specismo, e non mi ingannavo. Ma – come sottolinea proprio Sunaura Taylor – attribuire maggiore dignità, maggior valore o maggiori diritti a un individuo in virtù delle sue (presunte) superiori caratteristiche intellettive è, innanzitutto, una forma di abilismo. La prima volta che mi sono imbattuto in questa osservazione, non ho potuto fare a meno di dirmi: come ho fatto a non pensarci prima?.
L’approccio che mette in relazione abilismo e specismo si rivela dunque molto promettente, perché permette di leggere con maggiore efficacia entrambi i fenomeni, evidenziando una matrice comune all’esclusione sociale dei soggetti umani considerati disabili e alla marginalizzazione, spesso letale, degli animali non umani. Un tema che, di recente, è stato sviluppato anche in relazione al dibattito sulla neurodiversità.
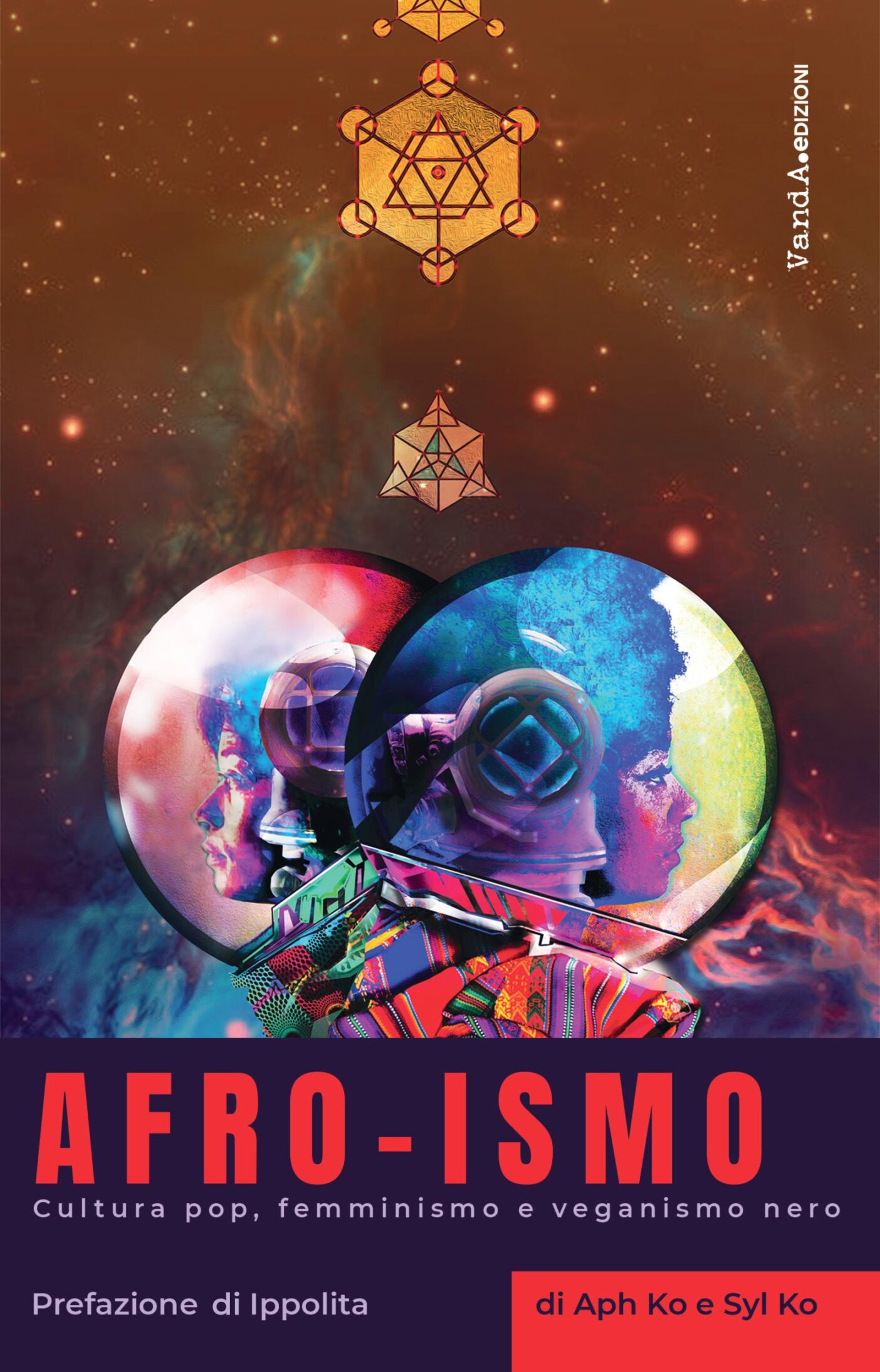
Le sorelle Ko parlano da una posizione precisa, quella di militanti del movimento Black Lives Matter che hanno abbracciato l’ideale della liberazione animale con tutte le sue implicazioni, a partire da quella – inevitabile per chi voglia dirsi antispecista – del veganismo. Da questa angolatura esprimono una serie di critiche situate: ai movimenti antirazzisti, spesso gravemente connotati in senso antropocentrico; ma anche a un discorso antispecista elaborato da persone bianche per altre persone bianche, che invisibilizza le tradizioni indigene di critica alla violenza di specie e le voci diverse da quelle del soggetto coloniale bianco.
Ne esce rivisitato anche un tema classico dell’antispecismo intersezionale, quello della tendenza a svalutare le esistenze delle minoranze, per poterle meglio sfruttare o marginalizzare, usando il paragone con gli animali non umani. L’animalizzazione, secondo le autrici, è un dispositivo che si costruisce in sinergia con la costruzione del concetto di razza. Specismo e razzismo, dunque, non possono essere smantellati separatamente.

Più esplorato appare il tema del legame fra femminismo e liberazione animale. Ortolani mette in dialogo una serie di autrici che hanno interpretato l’ecofemminismo in chiave antispecista, a partire dal lavoro pionieristico di Carol J. Adams, che ha evidenziato i nessi fra cultura dello stupro e cultura della carne. Accanto a quest’ultima, emergono le figure di Lori Gruen, Marti Kheel, Greta Gaard e Val Plumwood che, con accenti diversi fra loro, hanno contribuito a definire i contorni di quel filone che oggi chiamiamo “ecovegfemminismo”.
Su questo corpus si innesta la proposta queer di Rasmus Simonsen, che promuove un veganismo disturbante, in grado di contestare non solo la violenza sui corpi animali, ma anche l’ingiunzione all’eterosessualità obbligatoria, legata a doppio filo alla cultura (virilista) dell’alimentazione carnea. Se il vero uomo mangia carne, rifiutarsi di farlo significa rivendicare con orgoglio la propria solidarietà verso gli animali sfruttati, ma anche la propria dissidenza di genere.
La discussione dei rapporti fra questi testi articolata da Elisa Ortolani restituisce il quadro di un dibattito ricco, caratterizzato dall’intersezionalità come metodo utilizzato per sviluppare la critica allo specismo, per affrontare la questione animale all’insegna dell’intersezionalità. Il metodo intersezionale, infatti, permette di leggere i diversi piani di oppressione/privilegio nel loro rapporto, nel loro reciproco rafforzarsi, fornendo strumenti imprescindibili per smantellarli. Tuttavia, nella maggiorparte dei modelli intersezionali, il piano del privilegio di specie rimane sullo sfondo, sottorappresentato o, peggio, deliberatamente ignorato. E invece l’adozione dell’intersezionalità dovrebbe essere, come osserva David Pavón-Cuéllar,
né passiva né imitativa, ma attiva e creativa. […] L’intersezionalità andrebbe concepita come una soglia e non come un orizzonte, come un punto di partenza e non di arrivo, come una domanda e non come una risposta, come problema e non come soluzione al problema.
D. Pavón-Cuéllar, ¿Qué hacer con la interseccionalidad en la psicología crítica latinoamericana?, 2023, p. 176.
La proposta dell’autrice di Politiche dell’antispecismo è una convincente esortazione al mondo dei movimenti sociali ad attribuire piena dignità politica alle lotte di liberazione animale. Al tempo stesso, essa costituisce un utile esercizio di applicazione alle tematiche antispeciste di quel metodo intersezionale che nasce nell’ambito del femminismo afroamericano radicale.
Perché, in definitiva, la liberazione non può essere tale se lascia indietro qualcunə, a qualunque specie appartenga.
